
Raffaello, Ritratto di papa Leone X con i due cugini cardinali Giulio de’ Medici e Luigi de’ Rossi, 1518, Le Gallerie degli Uffizi, Firenze
- : Intervento di restauro
- Stato attività: concluso

Dati
- Strutture interne coinvolteSettore restauro Dipinti su tela e tavolaSupporti lignei
- Tipologia interventoindagini diagnosticheintervento conservativoprogetto di restauro
- Riferimento archivioGR 13561
- Durata intervento20/03/2017 – 27/02/2020
- Direzione tecnicaOriana Sartiani
- Direzione dei lavoriMarco Ciatti Cecilia Frosinini
- RestauratoriOriana Sartiani Andrea Santacesaria Luciano Ricciardi Ciro Castelli Francesca Brogi
- Indagini scientificheDocumentazione in luce diretta, radente e fluorescenza UV Roberto BellucciRadiografia X in digitale: Laboratorio di fisica dell’OPD diretto da Andrea Cagnini Ottavio Ciappi Daniele CiappiRiflettografia IR con scanner VIS NIR Roberto BellucciStrumentazione di CNR-INO Firenze, gruppo Beni Culturali: Raffaella Fontana, Jana Striova, Alice Dal Fovo, Enrico Pampaloni, Marco Raffaelli Analisi XRF per punti: Laboratorio scientifico dell’OPD diretto da Giancarlo LanternaAnalisi XRF a scansione: Pier Andrea Mandò, Anna Mazzinghi, Chiara Ruberto, Francesco Taccetti della rete CHNet dell’istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Firenze, dipartimento di Fisica Analisi morfologiche al microscopio ottico, al SEM-Eds e spettrofotometria: Laboratorio scientifico dell’OPD diretto da Giancarlo Lanterna Carlo Galliano Lalli Federica InnocentiFotogrammetria robotica: Anna Umattino, Giovanni Borelli, Luca Ponzio (Memooria s.r.l. – Tecnologie digitali per i Beni Culturali)
- Rilievo 3DPaolo Pingi, Eliana Siotto, Gianpaolo Palma del CNR-ISTI Visual Computing Lab, PisaAnalisi OCT e rilievo 3D mediante microprofilometria a scansione: Raffaella Fontana, Jana Striova, Alice Dal Fovo, Enrico Pampaloni, Marco Raffaelli del CNR-INO Firenze, gruppo Beni Culturali
- Data inizio20/03/2017
- Data fine27/02/2020
Informazioni sull’attività
Informazioni sull’opera
Informazioni storico-descrittive
Vicende conservative
Le vicende legate all’opera iniziano con il suo invio a Firenze nel settembre del 1518 in occasione delle nozze di Lorenzo de’ Medici, duca di Urbino, con Maddalena de la Tour d’Auvergne. Lo zio pontefice è rappresentato insieme a due cardinali, entrambi appartenenti alla famiglia Medici: i cugini Giulio de’ Medici (a sinistra) e Luigi de’ Rossi (a destra).
La prima citazione del capolavoro nelle collezioni medicee risale alla descrizione del Vasari riportata nella prima edizione delle Vite del 1550: «Fece in Roma un quadro di buona grandezza, nel quale ritrasse papa Leone, il cardinale Giulio de’ Medici e il cardinale de’ Rossi, nel quale si veggono non finite ma di rilievo tonde figure: […] La quale opera fu cagione che il Papa di premio grande lo remunerò; e questo quadro si trova ancora in Fiorenza nella guardaroba del Duca».
In quel tempo la tavola si trovava «nella sala dell’Appartamento nuovo della Guardaroba dove alloggiano ‘e’ forestieri’» come da inventario di Palazzo Vecchio del 27 ottobre 1553. Nella Guardaroba granducale di Palazzo Vecchio è confermato nelle revisioni inventariali tra il 1553 e il 1560 e ancora negli anni 1574-1575.
Dal 1589 fino a quasi tutto il Seicento risulta esposto nella Tribuna degli Uffizi, sopra la porta di ingresso. Viene poi trasferito a Palazzo Pitti quasi allo scadere del XVII secolo, nel 1697. All’inizio del Settecento risulta collocato nella Camera dell’Alcova dell’appartamento al primo piano del Gran Principe Ferdinando, riordinato da Cosimo III dopo la morte del figlio, dove sembra rimanere durante la Reggenza del primo periodo lorenese. Solo dopo il riordinamento degli appartamenti realizzato all’arrivo di Pietro Leopoldo, il ritratto di papa Leone X risulta collocato nell’Appartamento di Pietro da Cortona, nella sala di Marte, dove in seguito sarà spostata anche la Madonna della Seggiola.
Nel 1799 i francesi requisiscono il dipinto da Palazzo Pitti per portarlo a Parigi. Negli anni compresi tra il 1799 fino al 1816 viene sottoposto ad un intervento di pulitura diseguale e drastica. Viene poi restituito nel 1815 e ricollocato in galleria l’anno successivo nella sala di Marte.
Nel corso dell’Ottocento non si hanno notizie di altri interventi ma non si può escludere del tutto che il dipinto sia stato sottoposto a qualche manutenzione.
Dal 1940 al ‘45 l’opera subisce diversi spostamenti tra la villa di Poggio a Caiano, Camaldoli e il Museo degli Argenti. Dagli anni Ottanta del secolo scorso è stata esposta nella sala 26 degli Uffizi, detta di Raffello e di Andrea del Sarto.
L’ultimo intervento a cui viene sottoposto è stato realizzato da Alfio del Serra tra il 1995 e il 1996 in occasione della mostra dedicata all’opera all’interno degli Uffizi.
Dal 2012 viene spostato dalla sala 26 alla Sala 66 degli Uffizi al primo piano.
Tecnica esecutiva
Il dipinto è realizzato ad olio su un supporto ligneo e misura 155x119x3 cm.
Il tavolato è stato ottenuto impiegando cinque assi di legno di pioppo di scarsa qualità, con numerose nodosità e deviazioni della fibra. Una di esse (la quarta da sinistra guardando la pittura) presenta addirittura l’orientamento degli anelli di accrescimento del legno posto in senso contrario rispetto alle altre.
L’indagine radiografica ha evidenziato come le cinque assi di pioppo siano state accostate ed incollate a spigolo vivo, senza l’ausilio di elementi interni di collegamento. Una volta assemblato, il tavolato è stato dotato di due traverse a sezione trapezoidale “a coda di rondine”, inserite in apposite tracce ricavate nello spessore del legno; non è chiaro se una delle due sia stata sostituita in un precedente intervento di restauro o se siano entrambe autentiche.
Per l’approfondimento della tecnica pittorica è stata condotta l’analisi XRF puntuale e a scansione. Sono inoltre stati eseguiti: la fotogrammetria robotica, il rilievo 3D dell’intera superficie per lo studio e la documentazione dello stato morfologico dell’opera; l’indagine OCT (tomografia ottica coerente) per l’analisi stratigrafica/morfologica ad alta risoluzione per il monitoraggio della pulitura e il rilievo 3D mediante microprofilometria a scansione.
Il dipinto è stato realizzato su una sottilissima preparazione bianca, stesa sul supporto ligneo, in due mani, a base di gesso e colla animale, con più strati impermeabilizzanti di sola colla in superficie.
La stratigrafia procede con una sottile imprimitura di colore grigio chiaro, a base di bianco di piombo caricato di pochissimo nero di carbone e scagliette di vetro, stesa su tutta la superficie dell’opera.
Per quanto riguarda il disegno preparatorio, come la riflettografia mostra, Raffaello utilizza due metodi diversi di costruzione del disegno, ricavato da schizzi certo eseguiti separatamente dei tre prelati. Da questi appunti grafici egli ricava due cartoni da utilizzare “a spolvero” per la trasposizione sul dipinto. Per la figura del papa la riflettografia mostra un procedere più complesso e meno meccanico, senza l’utilizzo della puntinatura. Sono infatti molto riconoscibili e evidenti tratti piuttosto spessi, a mano libera, tracciati con un carboncino, che definiscono con una sintesi e, al tempo stesso, con straordinaria capacità fisiognomica e acutezza psicologica, i caratteri salienti e distintivi del volto di Leone X. La composizione del gruppo, dunque, avvenne per fasi differenziate, ma congrue e sincrone come progettazione e cronologia, senza alcun avvicendamento o ripensamento nella sua elaborazione.
La pellicola pittorica, probabilmente ad olio, realizzata con una precisa ma ristretta gamma di colori, è stesa sull’imprimitura grigio chiaro con spessori sottili ma comunque diversificati a seconda della rappresentazione degli elementi della composizione, in un rapporto cromatico armonico e con effetti di grande brillantezza.
Stato di conservazione
Prima dell’intervento di restauro il dipinto versava in buono stato di conservazione, pur mostrando alcune criticità legate al rapporto non ottimale tra il tavolato e il sistema di traversatura. Sul retro, sui bordi e lungo le testate del supporto è stata riscontrata la presenza di una stesura di resina acrilica applicata durante il restauro degli anni Novanta.
Con ogni probabilità, nell’Ottocento, la tavola fu oggetto di un intervento di restauro durante il quale una o entrambe le traverse furono sostituite. La documentazione del restauro del 1995-1996 e la testimonianza del restauratore Alfio Del Serra indicano diversi cedimenti nelle commettiture. Le sconnessioni risultavano piuttosto datate ed erano già state risanate con l’inserimento di tasselli “a farfalla” in legno di noce, durante un intervento probabilmente ottocentesco. Nel corso degli anni Novanta è stata riscontrata una ulteriore sconnessione delle commettiture delle assi sulle quali si era già intervenuti. Il degrado era piuttosto evidente sul retro del dipinto, mentre sul fronte il fenomeno appariva più contenuto. Durante il risanamento del supporto vennero alla luce numerose gallerie di insetti xilofagi talvolta anche di notevoli dimensioni. Con il restauro del 1995-1996 gran parte delle gallerie furono colmate con resina epossidica prima dell’incollaggio dei cunei. Nello stesso intervento risulta infine essere stata verificata la buona funzionalità delle due traverse.
La forza di contrasto tra le giunzioni delle assi e le due traverse poste sul retro avevano generato alcune fessurazioni e sollevamenti degli strati pittorici. Sul fronte, lungo la giunzione tra la seconda e la terza asse, guardando l’opera, è presente una lieve fessurazione degli strati pittorici, visibile in particolar modo sulla mano del pontefice poggiata sul tavolo, causata da una compressione tra gli elementi lignei.
I sollevamenti erano concentrati prevalentemente nell’area dove sono raffigurati la sedia camerale, il cuscino e la veste rossa di Luigi de’ Rossi (il cardinale a destra). Un’area del dipinto, questa, dove si è riscontrata la situazione di maggior degrado, con una morfologia superficiale particolarmente accidentata e caratterizzata da numerose creste di colore, in gran parte malamente compresse e frantumate durante antichi interventi sia di pulitura che di fermatura.
Fortemente disturbanti risultavano alcune ampie e disomogenee zone di sbiancamento prodotte da opacizzazioni della vernice e da ripassature pittoriche alterate. Particolarmente evidenti quelle diffuse sul fondo architettonico che, creando un effetto schiarente, ribaltavano i piani prospettici, portando lo sfondo in avanti e facendo arretrare le figure del primo piano.
Inoltre l’opera risultava a prima vista trattata pittoricamente con una cura meticolosa che comunicava però l’impressione di una generale mancanza di definizione: l’immagine risultava eccessivamente compatta e nello stesso tempo nebulosa, quasi indistinta nella definizione dei vari piani, fattore che limitava l’apprezzamento dell’alta qualità pittorica.
Numerose erano ad ogni modo le mancanze di colore, seppur di lieve profondità ed entità, evidenti soprattutto a luce radente nell’area in basso a destra, dove è stata dipinta, con profusione di vermiglione e lacca rossa, la sedia. Altre micro-lacune, molto ravvicinate tra loro, sono presenti laddove il pittore ha di nuovo utilizzato un’alta concentrazione di lacca rossa; così come nei massimi scuri delle pieghe delle vesti. Caratteristica che accomuna molte delle piccole, ma innumerevoli lacune è la presenza di stuccature ad olio, di colore e consistenza differenti, dal bruno-rosso al grigio scuro, realizzate nel corso di precedenti e antichi restauri. A queste più antiche tipologie di stuccatura si aggiunge quella di colore bianco realizzata con gesso e colla nel 1996, in strato sottile su lacune poco profonde. Purtroppo diverse di queste stuccature, integrate pittoricamente, si erano sollevate lungo il perimetro, forse a causa di una debole adesione agli strati preparatori sottostanti, forse non sufficientemente preparati a riceverle.
Nonostante i sollevamenti localizzati lungo la giunzione delle assi e lo stato di fatto delle aree sopra descritte, gli strati pittorici, nel loro insieme, non presentano problemi conservativi: la preparazione a gesso è infatti compatta e ben adesa al supporto ligneo e il colore agli strati preparatori sottostanti, nonostante alcune inevitabili sollecitazioni lungo le commettiture delle assi. Gli strati pittorici presentavano una craquelure molto sottile in zone circoscritte. Sull’ampio panno rosso della tovaglia sono state trovate tracce di antiche ripassature di restauro e ritocchi, così come abrasioni della materia pittorica originaria laddove, in passato, la materia stessa era stata aggredita per la rimozione di altri tenaci ritocchi, probabilmente ad olio, non facilmente solubili.
Altri interventi di restauro erano riconoscibili in corrispondenza di fori di uscita di tarli, stuccati anch’essi in epoche diverse con materiali di colore e natura differenti.
Sebbene l’ultimo restauro, effettuato da Alfio del Serra, risalisse a tempi relativamente recenti (1995-96), l’attuale intervento si è reso comunque necessario e urgente proprio per la presenza dei sollevamenti degli strati pittorici.
Descrizione intervento
L’intervento sul supporto è stato rivolto principalmente agli aspetti che riguardavano i movimenti del tavolato e il controllo esercitato dalle traverse.
La morfologia della superficie del dipinto è stata documentata durante le varie fasi operative tramite un rilievo profilometrico con sistema laser scanner.
Inizialmente sono state rimosse le traverse, consentendo all’opera di rilasciare l’energia trattenuta dal sistema di traversatura preesistente. Il dipinto, ormai privato del sistema di controllo, è stato dotato di un sostegno temporaneo finalizzato ad eseguire l’intervento di consolidamento e di pulitura della superficie pittorica. Al termine di questa prima parte della lavorazione è stato messo a punto il nuovo sistema di traversatura, ottenuto modificando le due traverse preesistenti e rifunzionalizzandole sulla base dei parametri elastici delle traverse provvisorie. Ciascuna delle vecchie traverse è stata sezionata in due parti, collegate tra loro da viti e molle registrabili che permettono di graduarne la flessibilità fino al livello ritenuto ottimale.
Il restauro della superficie pittorica ha preso avvio con il controllo e la fermatura dei sollevamenti di colore riscontrati nell’area posta tra la sedia camerale e la veste di Luigi de’ Rossi, un’area dove si sono rilevati i maggiori segni di sofferenza della pittura e dove, inoltre, si è potuta constatare la presenza di numerosi ritocchi pittorici, di natura e di epoche diverse, che andavano a livellare in modo disomogeneo i dislivelli causati dalle innumerevoli micro-lacune.
Al fine di recuperare i caratteri propri della pittura di Raffaello alterati dalle soffuse velature e ripassature che avevano trasformato le cristalline campiture originarie sono stati effettuati il graduale assottigliamento e la rimozione della vernice tramite soluzioni acquose e miscele di solventi a bassa polarità, con l’uso di supportanti, e con emulsioni gelificate. Il procedere per diversi gradi di assottigliamento, è stato costantemente verificato nel corso del lavoro sotto luce ultravioletta, e indagine OCT per alcuni dettagli. I dati forniti dalle più recenti indagini, la relazione e la documentazione fotografica del restauro del 1996, sono stati costantemente consultati al fine di procedere in maniera mirata, in particolar modo sulle zone più compromesse.
È stato possibile identificare, in alcune aree e al di sotto degli strati di vernice, una sorta di disomogenea patina di colore grigio, corrispondente, con molta possibilità, a quella che Del Serra aveva considerato come una vernice grigia di natura proteica. Dopo essere giunti alla constatazione del notevole incupimento e appiattimento dei volumi e delle cromie che essa aveva prodotto, in modo particolare sui volti, abbiamo proceduto ad una rimozione selettiva. L’alleggerimento delle stratificazioni e velature soprammesse, ha permesso di apprezzare meglio alcuni dettagli dei volti importanti per la resa anatomica dei personaggi e dei passaggi chiaroscurali.
Alcuni piccoli residui di stuccature oleose, tenacemente ancorati alla policromia della sedia camerale, della nappa e del cuscino, già fortemente compromessa da interventi otto-novecenteschi, sono stati mantenuti, così come nel precedente restauro, per non rischiare di danneggiare ulteriormente la materia pittorica. Laddove invece è stato possibile operare in sicurezza per il recupero di porzioni di materia originaria, la rimozione di rifacimenti e di residui di stuccature è stata condotta grazie all’azione specifica di solventi di natura organica e acquosa e con il contributo di emulsioni gelificate a differenti valori di pH. In taluni casi la rimozione ha richiesto un’azione più puntuale, condotta con il mezzo meccanico del bisturi sotto il controllo dello stereomicroscopio.
Il restauro è continuato con la stuccatura delle piccole lacune, e con la revisione di altri vecchi stucchi, completati con il collegamento morfologico della superficie. Si è proseguito con la reintegrazione pittorica ad acquerello, con il metodo della selezione cromatica laddove possibile, viste le esigue dimensioni delle lacune, seguite dall’applicazione, a pennello, di una verniciatura con resina mastice. Il completamento del ritocco è stato realizzato con colori a vernice.
La protezione finale del film pittorico è stata eseguita con vernice nebulizzata a spruzzo per ottenere una maggiore uniformità di riflessione dell’andamento superficiale.
Al termine del restauro il dipinto è stato disinfestato mediante anossia in atmosfera modificata e successivamente protetto sul retro con un prodotto antitarlo steso a pennello a scopo preventivo.
L’opera è stata quindi nuovamente inserita nella sua cornice di galleria, anch’essa restaurata per l’occasione e dotata, appositamente per la mostra, di un vetro dalle particolari caratteristiche antiriflesso. Il Ritratto è stato sistemato in un alloggiamento perimetrale appositamente sagomato per seguire il nuovo profilo assunto dalla tavola. È stato infine fermato in cornice tramite particolari appoggi provvisti di molle che consentiranno i naturali movimenti del supporto senza interferire con il nuovo sistema di traversatura.
Bibliografia
Raffaello e il ritorno del Papa Medici: restauri e scoperte sul Ritratto di Leone X con i due cardinali, a cura di Marco Ciatti, Eike D. Schmidt, Firenze 2020
Galleria fotografica


Retro

Fluorescenza UV
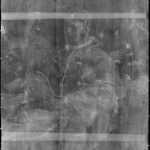
Radiografia

Riflettografia infrarossa dettaglio viso

Riflettografia infrarossa

Durante la fase di pulitura_particolare

Durante la fase di pulitura_particolare in fluorescenza UV

Durante la fase di stuccatura

Durante la fase di integrazione pittorica

Dopo il restauro

Dopo il restauro_particolare

Dopo il restauro_particolare

Dopo il restauro_particolare
Altre attività
Scopri di più

Intervento di restauro Francesco Hayez, Corpus di disegni, XIX sec., Accademia di Brera, Milano



Intervento di restauro Volto Santo, VIII-IX sec., Cattedrale di San Martino, Lucca


Sezione successiva

