
Artista non riconosciuto Yaka, Kholuka o Mbala, prima metà del XX sec., Collezione Peggy Guggenheim, Venezia
- : Intervento di restauro
- Stato attività: concluso

Dati
- Denominazione operaKholuka o Mbala
- Periodo cronologicoprima metà del XX sec.
- Tipologia Oggettocopricapo polimaterico
- Materialilegno intagliato e dipinto; fibre vegetali intrecciate, annodate, tessute e dipinte
- Misure53x40x38 cm
- CollocazioneCollezione Peggy Guggenheim, Venezia
- Strutture interne coinvolteSettore restauro Sculture lignee policrome
- Tipologia interventointervento conservativoprogetto di allestimentoprogetto di restauro
- Riferimento archivioGR 14047
- Direzione storico-artisticaCecilia Frosinini
- Direzione tecnicaLuciano Pensabene Buemi Peter Hans Stiberc
- RestauratoriSara Bassi Claudia Napoli
- Indagini scientifiche Giancarlo Lanterna
- Documentazione fotograficaGiuseppe Zicarelli
- Enti e persone coinvolte
Collezione Peggy Guggenheim di Venezia
Direttrice Collezione Peggy Guggenheim: Karole Vail
Department of Visual Art and Art History, Wheaton College, Norton, Massachusetts: Ellen McBreen (prof.ssa associata di storia dell’arte)
National Museum of World Cultures, Amsterdam, Berg en Dal, Leiden e Rotterdam: Fanny Wonu Veys (curatrice)
Guggenheim Museum, New York: Vivien Greene (senior curator, 19th- and Early 20th-Century Art) - Data inizio15/10/2019
- Data fine07/02/2020
Informazioni sull’attività
Informazioni sull’opera
Informazioni storico-descrittive
L’opera proviene dalla Repubblica Democratica del Congo.
I copricapi Yaka venivano indossati durante le danze che sancivano la fine del periodo iniziatico (nkanda oppure n-khanda) e costituivano una protezione rituale nel passaggio dall’infanzia all’età adulta, nonché una propiziazione per la fertilità. Durante i riti, i danzatori rappresentavano gli antenati civilizzatori che avevano istituito la tradizione della circoncisione e, indossando le maschere, riattivavano e rinvigorivano la loro forza vitale per trasmetterla ai discendenti.
In particolare, i copricapi kholuka, comunemente detti mbala, sono caratterizzati dalla presenza alla sommità dell’acconciatura di figure antropomorfe che richiamano i motivi cantati durante la celebrazione. Spesso tali figure fanno riferimento ad atti sessuali e, quindi, simboleggiano la fertilità maschile. Anche la maschera frontale richiama il tema della fertilità e il simbolismo cosmologico: la struttura circolare concentrica che inquadra e delimita il volto rappresenta il ciclo cosmico del sole e della luna; il naso ricurvo verso l’alto, tipico dello stile degli Yaka, viene interpretato da alcuni studiosi come raffigurazione della proboscide dell’elefante, da altri come simbolo fallico; e linee che scendono dagli occhi sono un riferimento alle sofferenze del periodo iniziatico; e fibre dell’acconciatura, che rivestono un ruolo di protezione, simboleggiano la palma fertile.
Ogni copricapo della cerimonia nkanda assumeva un nome diverso in base al grado di chi la indossava: nello specifico, il copricapo kholuka era prerogativa del tutore più anziano del campo iniziatico (n’langala), anche se alcune fonti fanno riferimento all’iniziato più anziano. La sua esibizione avveniva singolarmente – non in coppia come le altre – e costituiva la parte finale e più estrosa della danza (kinkanda).
Poco prima che il rituale avesse luogo, gli organizzatori commissionavano allo scultore (kalaveni oppure n’kalaweeni, letteralmente “colui che esercita la funzione per eccellenza”) la riparazione e il rinnovo della policromia delle vecchie maschere sopravvissute alle precedenti iniziazioni e, se necessario, la costruzione di nuove. Infatti, mentre gli altri copricapi confezionati dagli iniziati erano di proprietà personale e venivano bruciati alla fine della danza, quelli kholuka invece venivano conservati. Prima di cominciare la costruzione di un copricapo, lo scultore, possessore anche di conoscenze esoteriche, offriva doni al proprio maestro, vivo o morto che fosse. Il lavoro veniva eseguito in prossimità del campo d’iniziazione, ma non poteva essere osservato dai nuovi circoncisi e dai non iniziati, motivo per cui i copricapi conclusi venivano tenuti nascosti fino al giorno della cerimonia. L’artista selezionava un particolare albero della foresta, lo lasciava esiccare all’ombra per diversi giorni, e lo sgrossava con un’ascia chiamata khaandu; infine, intagliava i dettagli con un piccolo coltello (misendo). Prima veniva scolpito il viso, poi il manico. Alla maschera venivano poi praticati dei fori tramite calore, che servivano per ancorare l’acconciatura e la struttura interna del casco. Su quest’ultimo veniva adagiato e cucito un tessuto di fibre vegetali impregnato di una resina trasparente (ngondasala), su cui poi veniva steso il colore per mezzo di piume di gallina o bastoncini. Infine, lo scultore applicava la policromia sulla maschera frontale. Venivano inseriti, tra i materiali costitutivi, anche potenti ingredienti derivati da diversi amuleti, nonché le ceneri ricavate dalla combustione del naso di un copricapo usato in un’iniziazione precedente.
Alla fine degli anni ’50, Peggy Guggenheim arricchì di opere d’arte allora definite “primitive” la sua dimora veneziana e la sua collezione. Tale interesse trova le sue radici nel periodo della breve e tormentata relazione sentimentale con l’artista surrealista Max Ernst, con il quale visse a New York tra il 1941 e il 1943. È ampiamente documentata, anche dagli stessi racconti di Guggenheim, l’irrefrenabile passione che Ernst aveva soprattutto per manufatti provenienti dalle Americhe e dalle isole oceaniche, che comprava quasi compulsivamente ogni volta che vendeva un suo quadro e con cui riempiva la loro casa newyorkese. La maggior parte delle opere veniva acquistata dal proprietario di una delle maggiori gallerie d’arte di New York, l’ebreo berlinese rifugiato Julius Carlebach, che la collezionista conobbe personalmente nel ’42. Inoltre, vale la pena menzionare che nel 1938 Robert Goldwater aveva avviato, con la pubblicazione del suo Primitivism in Modern Art, un intenso dibattito culturale nei salotti frequentati dagli artisti, dagli intellettuali, dalla ricca borghesia e dai grandi galleristi, paragonabile a quello avvenuto a Parigi nel 1905 sulla cosiddetta Art nègre, se non addirittura maggiore. Fondamentale e indicativa fu, in tal senso, l’apertura delle prime importanti esposizioni temporanee a carattere monografico nei principali musei e gallerie degli Stati Uniti, primo tra tutti il MoMA di New York, cui Guggenheim partecipò, seppur senza grande entusiasmo. Quando Ernst nel ’43 lasciò la loro casa a seguito del naufragio della relazione, portò via con sé tutte le opere della sua collezione. Una volta trasferitasi a Venezia, la collezionista iniziò finalmente a interessarsi, stavolta in modo diretto e appassionato, all’arte “primitiva”. Nella primavera del 1959, durante un lungo viaggio in Messico e negli Stati Uniti, visitò la galleria di Carlebach e da lui acquistò un primo ricco nucleo di dodici opere d’arte oceaniche, africane e precolombiane; lei stessa scrive: «Cominciai ad acquistare l’arte precolombiana e primitiva e nelle settimane successive mi ritrovai orgogliosa proprietaria di dodici fantastici oggetti di artigianato: si trattava di maschere e sculture della Nuova Guinea, del Congo Belga, del Sudan Francese, del Perù, del Brasile, del Messico e della Nuova Irlanda». Tale interesse si consolidò dopo il suo rientro a Venezia, e Peggy Guggenheim continuò ad acquistare oggetti di arte “primitiva” un po’ per volta, arrivando a possedere una cinquantina di pezzi, in parte maggiore rimasti nella collezione, in parte passati agli eredi. Venti di questi manufatti furono presentati nel primo grande catalogo della collezione veneziana, curato da Nicolas e Elena Calas, in una specifica sezione intitolata Primitive Art. La collezionista esponeva queste opere accostandole ai dipinti e alle sculture dei suoi artisti preferiti nelle stanze di Palazzo Vernier dei Leoni, come raffinati oggetti d’arredo, come testimoniano numerose fotografie d’epoca conservate nell’archivio fotografico.
L’opera è stata esposta nella mostra Migrating objects. Arte dall’Africa, dall’Oceania e dalle Americhe nella Collezione Peggy Guggenheim, allestita nel padiglione delle esposizioni temporanee del museo dal 15 febbraio 2020 al 10 gennaio 2022 (sospesa temporaneamente per la pandemia di COVID-19).
https://www.guggenheim-venice.it/it/mostre-eventi/mostre/migrating-objects/
https://www.guggenheim-venice.it/en/art/works/headdress-pg254/
Tecnica esecutiva
Il copricapo è composto da tre elementi principali:
- una maschera lignea antropomorfa con manico inferiore;
- un casco in fibre vegetali tessute, decorato alla sommità da una figura maschile seduta e rappresentata nell’atto di suonare un tamburo, che tiene tra le gambe;
- una fitta acconciatura in fibre vegetali.
La maschera lignea e il manico, che da fonti bibliografiche risultano essere intagliati in un legno leggero della specie Alstonia congensis oppure Ricinodendron heudelotii, sembrano costituire un unico pezzo.
Attorno al perimetro della maschera corre una doppia fibra vegetale semirigida che, sul retro, forma una struttura circolare; su questa sorta di “telaio” è cucito il bordo inferiore del casco in fibre vegetali tessute e sono annodate tutte le fibre che costituiscono la folta capigliatura. Dentro il casco si trova un’ulteriore struttura, sempre costituita da fibre semirigide intrecciate, che forma una specie di cestino ribaltato, con la funzione di controforma per la calotta.
Alla sommità del copricapo è ancorato tramite nodi un disco in fibra vegetale semirigida che funge da base per la figura apicale. Quest’ultima è realizzata con le stesse fibre vegetali tessute del capo e del disco, opportunamente cucite e riempite con materiale di origine vegetale per conferirgli i volumi; testa, mani, piedi e tamburo sono invece in legno. Anche il rivestimento della faccia apicale del tamburo è in fibre tessute, a simulare la pelle o membrana dello strumento. Tutti i componenti sono fissati tra loro tramite articolati sistemi di nodi e cuciture, mentre l’ancoraggio tra le mani e il tamburo è di tipo puntuale, per mezzo di chiodi metallici. Infine, i fianchi della figura sono assicurati al tamburo ligneo tramite cordicelle intrecciate, tese e annodate, che consentono di mantenerla in posizione seduta. Il suonatore presenta sulla testa cinque fori, in particolare due in corrispondenza delle orecchie e tre sul copricapo, che a sua volta indossa, che potrebbero ipoteticamente essere serviti per l’inserimento di elementi decorativi, ad ora perduti.
La maschera, il casco e la figura apicale presentano una ricca policromia con decorazioni geometriche di colore bianco, nero, rosso, blu, azzurro e rosa. Dall’osservazione diretta e dalle indagini stratigrafiche la policromia sembra essere costituita da una base cromatica nera (probabilmente il pigmento è ricavato da legni combusti e forse è applicata in doppia stesura, di cui la seconda contenente maggiori quantità di legante) su cui sono stesi poi il bianco (di titanio), il blu (blu di Prussia e ftalocianine), il rosso (terre e ocre) e l’azzurro, lasciando alcune zone “a risparmio” per sfruttare la colorazione nera. In moltissime aree la base cromatica nera risulta attualmente visibile a causa della perdita degli strati pittorici soprastanti.
Le analisi diagnostiche condotte hanno permesso di ottenere informazioni più dettagliate sulla tecnica esecutiva e sui materiali costitutivi (identificazione dei pigmenti e dei coloranti tramite XRF; osservazione al M.O. delle sezioni stratigrafiche del film pittorico e saggi microchimici per la caratterizzazione di pigmenti, coloranti e leganti; radiografia per la tecnica di realizzazione).
Stato di conservazione
L’opera versava in un precario stato di conservazione riconducibile sia ai naturali processi di invecchiamento dei materiali costitutivi (alcuni particolarmente fragili), sia all’usura legata all’impiego del copricapo come oggetto rituale.
Ulteriori fattori di degrado sono ascrivibili al clima tropicale del luogo d’origine e alla fragilità intrinseca della tecnica esecutiva, con riferimento particolare al tipo di legante pittorico impiegato e alle fibre della capigliatura. Una volta musealizzato, il manufatto è stato conservato a lungo senza un’adeguata protezione dalla polvere, dalle componenti infrarosse e ultraviolette della radiazione luminosa e dalle variazioni termoigrometriche ambientali, e ciò ha contribuito a infragilire ulteriormente i materiali costitutivi.
L’intera superficie era interessata da uno spesso strato di depositi di particolato atmosferico incoerente e coerente, concentrato soprattutto tra fibre vegetali della capigliatura e nella trama del tessuto che costituisce il casco e il corpo del personaggio apicale.
Le fibre vegetali erano irrigidite, deformate e in molti casi spezzate o distaccate e soggette a costanti e abbondanti cadute e perdite. Sul retro del casco policromo e della capigliatura si evidenzia una zona annerita, presumibilmente derivata da una combustione legata all’utilizzo cerimoniale.
La fibra vegetale del casco e della figura presentava alcune lacerazioni in corrispondenza dei punti di ancoraggio con la struttura portante della criniera e della maschera.
L’intera policromia era interessata da una forte frammentazione e da diffusi sollevamenti e cretti, che in molti casi hanno portato alla formazione di lacune. Il colore risultava decoeso sul casco e sulle campiture azzurre, blu e rosa della maschera. Sulle aree bianche e rosa della maschera era presente uno strato filmogeno ingrigito, probabilmente successivo (forse un protettivo o una colla).
Le parti lignee risultavano strutturalmente stabili.
Interventi precedenti
Non sono documentati, anche se alcuni elementi fanno supporre che in passato siano stati eseguiti degli interventi di restauro. Questi potrebbero essere stati realizzati nel luogo d’origine a seguito di danni da usura, in occasione della commercializzazione del manufatto, durante la permanenza nella collezione di Peggy Guggenheim o ancora in concomitanza con l’esposizione della maschera alla mostra Ethnopassion. La collezione d’arte etnica di Peggy Guggenheim tenutasi nel 2008 presso la Galleria Gottardo di Lugano e nel 2009 presso la Fondazione Mazzotta di Milano.
Al momento del nostro intervento erano infatti presenti: una sostanza filmogena lucida e ingrigita sulle campiture bianche e rosa della maschera lignea; un filo metallico intrecciato sul retro a formare un gancio sotto la capigliatura, che potrebbe costituire verosimilmente una soluzione espositiva precedente a quella attuale; infine, in corrispondenza della bruciatura, le fibre vegetali della capigliatura apparivano lucide, fenomeno che potrebbe essere attribuibile all’effetto della combustione oppure a un consolidamento pregresso.
https://www.guggenheim-venice.it/it/stampa/comunicati-stampa/ethnopassion/
Descrizione intervento
Durante l’intervento di restauro, l’opera non è stata rimossa dal suo piedistallo a causa dell’eccessiva fragilità delle fibre della capigliatura.
L’intera superficie è stata pulita meccanicamente tramite microaspiratore Faset Mod. 206 (vuotometro impostato a 30-40 kPa), mediante l’impiego di ugelli di differente forma e dimensione. Dove possibile, è stato eseguito il dry cleaning tramite spugne poliuretaniche del tipo PU sponge.
Previ opportuni test di solubilità e di sensibilità all’acqua, con tamponcini di cotone e con PU sponge imbevuti di acqua aggiustata a pH 7,5 è stata effettuata la pulitura delle fibre vegetali della capigliatura, della tela, di alcune aree della pellicola pittorica e del manico.
Dopo aver eseguito alcuni test per selezionare il consolidante più idoneo, è stato scelto l’adesivo di origine vegetale Funori. L’alga liofilizzata è stata fatta rigonfiare in acqua demineralizzata a diverse percentuali di concentrazione per 24 ore; la soluzione è stata quindi riscaldata a bagnomaria per 20 minuti a circa 80°C e poi filtrata. È stato effettuato il consolidamento a pennello delle seguenti aree:
- campiture bianche, azzurre, rosa e rosse della maschera con Funori all’1%;
- fibre vegetali tessute del casco e del corpo della figura apicale con Funori allo 0,5%;
- policromia del casco e del corpo della figura apicale con Funori all’1%;
- fibre vegetali intrecciate e annodate varie con Funori allo 0,5%;
- fibre vegetali della capigliatura in corrispondenza dei nodi di ancoraggio al casco con Funori al 2%.
La campitura blu della maschera, particolarmente decoesa, è stata consolidata con Funori all’1% applicato per gocciolatura, mantenendo l’opera in posizione orizzontale tramite una struttura di supporto temporanea appositamente realizzata.
I sollevamenti di colore, presenti sulla campitura bianca della maschera e diffusi su tutta la policromia del casco e della figura apicale sono stati fatti riaderire con Funori al 2% applicato a pennello.
Le fibre vegetali dell’acconciatura sono state, ove possibile, districate e ridistese. È stato quindi effettuato un consolidamento tramite nebulizzazioni di Funori all’1%.
Bibliografia
- N. CALAS, E. CALAS, The Peggy Guggenheim Collection of Modern Art, Harry N. Abrams, New York 1967, pp. 249-263
- P. GUGGENHEIM, Una vita per l’arte. Confessioni di una donna che ha amato l’arte e gli artisti, Rizzoli, Milano 1998, p. 371
- F. P. CAMPIONE (a cura di), Ethnopassion. La collezione d’arte etnica di Peggy Guggenheim, Mazzotta, Milano 2008, pp. 18-20, 28, 30-38, 45, 174-177
- V. GREENE (a cura di), Migrating objects. Arte dall’Africa, dall’Oceania e dalle Americhe nella Collezione Peggy Guggenheim, Venezia 2020, pp. 50, 117-119
- S. BASSI, C. NAPOLI, L. PENSABENE BUEMI, L’altro volto del Novecento: arte dall’Africa, dall’Oceania e dalle Americhe. L’esperienza di restauro e manutenzione sugli “oggetti migranti” della Peggy Guggenheim Collection di Venezia, in OPD Restauro n. 32, 2020, pp. 230-242
Galleria fotografica


Particolare prima del restauro

Particolare prima del restauro

Particolare prima del restauro

Particolare prima del restauro

Radiografia
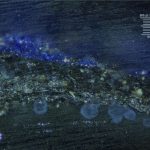
Sezione stratigrafica

Mappatura degli interventi di restauro

Microaspirazione

Microaspirazione

Consolidamento del colore

Fronte dopo il restauro

Lato sinistro dopo il restauro

Retro dopo il restauro

15
Altre attività
Scopri di più

Intervento di restauro Francesco Hayez, Corpus di disegni, XIX sec., Accademia di Brera, Milano



Intervento di restauro Volto Santo, VIII-IX sec., Cattedrale di San Martino, Lucca

Sezione successiva

