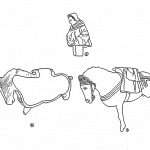
Jacopo della Quercia (attr.), Gruppo Equestre, XV sec., Pieve di San Cassiano di Controne, Lucca
- : Intervento di restauro
- Stato attività: concluso

Dati
- Denominazione operaGruppo Equestre
- AutoriAttribuito aJacopo della Quercia
- Periodo cronologicoXV sec.
- Tipologia Oggettoscultura lignea policromastatua
- Materialilegno intagliato e dipinto
- CollocazionePieve di San Cassiano di Controne, Lucca
- Strutture interne coinvolteSettore restauro Sculture lignee policrome
- Tipologia interventoindagini diagnosticheintervento conservativoprogetto di restauro
- Riferimento archivioGR 10424
- Direzione storico-artisticaGiovanna Rasario
- RestauratoriMaria Donata Mazzoni Gianluigi Canocchi
- Indagini scientificheDirezione scientifica: Mauro MatteiniIndagini diagnostiche: Mauro Matteini Arcangelo MolesRX: Alfredo Aldrovandi Ottavio CiappiEnti collaboratori alle indagini fisiche: Istituto di Assestamento e Tecnologia del legno, Facoltà di Scienze Forestali, Università di Firenze (Marco Fioravanti, Luca Uzielli), Istituto per la ricerca sul legno CNR Firenze (Anna Gambetta)
- Documentazione fotograficaSergio Cipriani
Informazioni sull’attività
Informazioni sull’opera
Informazioni storico-descrittive
Ritrovato da Peleo Bacci, soprintendente ai monumenti di Pisa dal 1910 al 1923, in pezzi in un deposito di legna, fu restaurato nel 1920 ed attribuito alternativamente a Francesco di Valdambrino (Ragghianti, Carli, del Bravo) e a Jacopo della Quercia (Belli Barsali, Middeldorf, Storm). Al suo ritrovamento il gruppo equestre fu creduto un san Martino, da altri un sant’Ansano. Carlo Ludovico Ragghianti nel 1938 lo attribuisce a Valdambrino ritenendolo un san Cassiano. La rimozione degli strati sovrapposti, delle pesanti ridipinture e stuccature dell’intervento novecentesco, che nascondevano l’elegante plasticismo, ha permesso a Giovanna Rasario di restituire l’opera al corpus di Jacopo della Quercia. Insieme al Sepolcro Savelli di S. Maria Gloriosa ai Frari a Venezia è l’unico gruppo equestre ligneo quattrocentesco sopravvissuto fino ai nostri giorni.
Tecnica esecutiva
Il Gruppo Equestre è costituito da tre elementi in legno di Tiglio. Il cavallo è stato ricavato da due grandi semitronchi uniti in un solo blocco mediante perni lignei (ancora esistenti), scalpellando una parte centrale a forma cubica per creare l’innesto del corpo del cavaliere. Cavaliere e cavallo sono quindi stati sbozzati “pieni” per avere una struttura solida, resa ancora più stabile dall’incastro quadrangolare del cavaliere. Dopo una prima sbozzatura, il cavallo è stato riaperto a metà per svuotarlo internamente così da limitare le tensioni del legno e gli spacchi radiali. Successivamente il corpo del cavallo è stato richiuso. Unici elementi aggiuntivi sono le zampe assemblate tramite incastro a mezza pialla, fermato con chiodi in ferro. Il cavaliere è intagliato da un unico parallelepipedo di legno, inserito sul dorso del cavallo nello spazio destinato tramite un grosso perno di forma cubica.
La superficie lignea, dopo essere stata saturata con colla animale, ha ricevuto una sottile ammannitura con gesso e colla. La policromia originale è costituita da tempera a uovo.
Stato di conservazione
Del Gruppo Equestre di San Cassiano rimangono il busto del cavaliere, privo delle braccia, ed il corpo del cavallo, al quale è rimasta collegata la sola zampa anteriore sinistra. Le altre tre zampe, distaccatesi a livello dell’incastro con il corpo, sono purtroppo andate perdute. L’uso di chiodi per unire gli incastri a doppia pialla, invece di perni lignei, ha probabilmente contribuito a questa perdita. Il supporto ligneo aveva inoltre subito un’infestazione d’insetti xilofagi che ha contribuito all’indebolimento e all’abrasione della superficie. La policromia presentava innumerevoli sollevamenti e cadute di colore, oltre alla sovrammissione di un pesante stucco e di una ridipintura deturpanti. Il cavaliere era ridipinto con colori di pessima qualità e piuttosto lacunosi.
Interventi precedenti
L’opera ha subito un importante intervento di restauro ai primi del novecento, data individuata dal telegramma inviato dal parroco di San Cassiano nell’ottobre del 1920, in cui si comunica alla Soprintendenza di Firenze l’invio della scultura del «santo cavaliere e del cavallo al restauro», nonché dalle date delle foto del 1913 prima e del 1926 dopo il restauro. Nel restauro novecentesco è stato eseguito un grosso lavoro strutturale operando sul cavallo “aperto”, visto l’inserimento di traverse interne e zeppe su tutta la struttura. Nella richiusura è stato privilegiato il muso del callo a discapito delle altre parti. Per ovviare alle imperfezioni dell’incollaggio e alle abrasioni del legno provocate dall’azione dei tarli è stato steso, in maniera discontinua, uno strato di stucco mischiato a cemento, molto deturpante e occlusivo per il modellato. Dello stesso intervento conservativo fanno parte alcune ricostruzioni del modellato mancante in legno di cirmolo, sia nel cavallo che nel cavaliere. Per uniformare i vari interventi l’intera superficie dell’opera era stata patinata con varie mani di cera pigmentata. Probabilmente ottocentesca era, invece, la ridipintura del volto e dei capelli del cavaliere e quella presente sul mantello e sul cappuccio di colore rosa.
Descrizione intervento
Come primo intervento, dopo la spolveratura della superficie con pennelli morbidi, l’opera è stata messa in sicurezza fermando i sollevamenti di colore con iniezioni di colla di coniglio al 1:14. Le fermature si sono susseguite anche durante l’intervento di pulitura a causa della fragilità dello strato pittorico.
Dopo le indagini diagnostiche e le varie prove di pulitura, nonostante la grande quantità di lacune della policromia originale (circa il 40% della superficie), è stato deciso di rimuovere la ridipintura ottocentesca in quanto anch’essa molto lacunosa e di pessima qualità. La ridipintura è stata rimossa a secco con l’uso del bisturi sotto microscopio, vista l’impossibilità dell’impiego di solventi.
Per il risanamento strutturale si è reso necessario asportare lo stucco applicato sulla superficie lignea lasciando a vista le abrasioni del legno. Queste sono state riempite con cere colorate per eliminare la frammentarietà del modellato e, nelle parti più rovinate, con una tassellatura in legno di tiglio. Sono state invece mantenute le integrazioni lignee di modellato in cirmolo, in quanto riconoscibili e ben proporzionate. Dopo la TAC, che ha evidenziato una sconnessione tra la testa e il busto del cavaliere, si è deciso di inserire nella struttura un perno ligneo per collegare e mettere in sicurezza le due parti.
Vista la condizione lacunosa della policromia, l’intervento di integrazione pittorica ha riguardato solo le piccole perdite, ricucendo a selezione cromatica le parti frammentarie e lasciando a legno le ampie mancanze. Per tale operazione sono stati impiegati stucco a gesso e colla animale e colori ad acquerello. Le integrazioni lignee sono state patinate sempre con colori ad acquerello.
L’opera è stata infine protetta con cera microcristallina stesa a pennello.
Bibliografia
- G. RASARIO, Il Cavaliere di San Cassiano. Opificio delle pietre dure di Firenze e del Museo Nazionale del Bargello, S.p.e.s., Firenze, 1995.
- G. RASARIO, G. CANOCCHI, Sculture lignee policrome: modelli operativi di restauro, in OPD restauro n.6, Centro Di, Firenze, 1994, pp. 68-77
Galleria fotografica
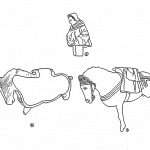

Prima del restauro – retro

Prima del restauro. Si nota il sistema d’incastro quadrangolare del cavaliere al cavallo

Particolare del punto d’innesto del corpo del santo nel cavallo

Particolare dell’integrazione lignea sul collo del cavallo eseguita a tasselli

Particolare dell’integrazione lignea eseguita a tasselli sulla criniera

Dopo il restauro

Particolare dopo il restauro

Particolare del cavaliere dopo il restauro

Immagine RX. Si nota la presenza di chiodi per l’assemblaggio del Gruppo Equestre
Altre attività
Scopri di più

Intervento di restauro Francesco Hayez, Corpus di disegni, XIX sec., Accademia di Brera, Milano



Intervento di restauro Volto Santo, VIII-IX sec., Cattedrale di San Martino, Lucca


Sezione successiva

